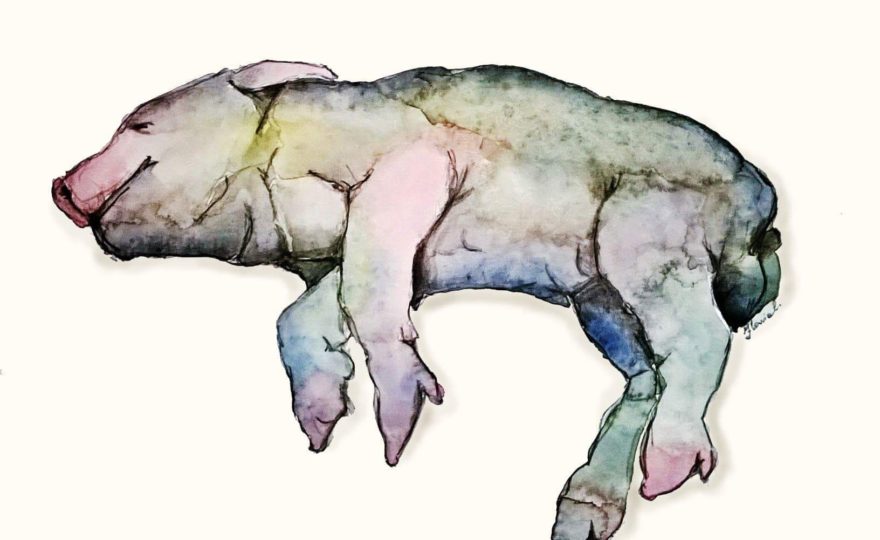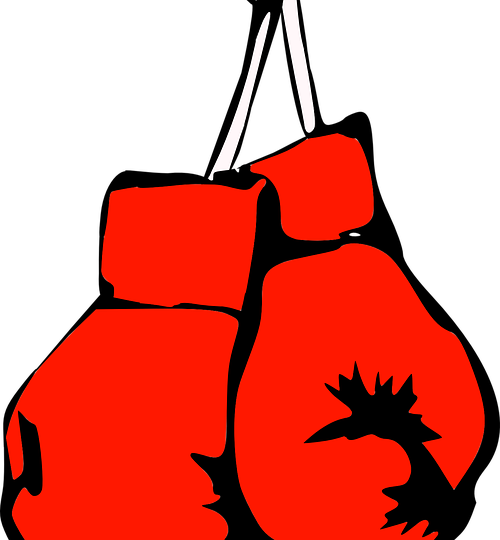di
Federico Cirillo
Gli altri. È sempre pieno di altri qui sul 23.
Tutti diversi ma tutti così diversamente accomunati da una cosa: il tragitto. Anzi no, in realtà da due cose: il tragitto e farsi i cazzi degli altri.
Ed eccoli qua:
«Te dico che è così a Fa’…non ce volevo crede!»
«Si, ma è assurdo! Ma lei non se n’è mai accorta?»
«Ma chi, Camilla? Macché! La conosci mi sorella no? Se fidava. D’altronde stanno insieme da quando so’ regazzini!»
«Si, però checcazzo! Io posso pure capi’ co n’altra, lo posso accetta’: ma così è pesante eh»
«Pesante sì. Pensa che l’ha sgamato a vede pure i video sull’internet: gli ha preso il telefono e ha trovato di tutto! Foto, video, messaggi co tutti quelli come lui!»
«Assurdo, assurdo, n’ce se crede. Ma poi così, senza un cenno de preavviso o un sintomo?»
«Eh, così, all’improvviso. Che poi comunque lui ha sempre fatto parte del gruppo nostro e noi bene o male, stiamo sempre a parla’ de quello. Però, guarda, te posso dì che sinceramente lo vedevo sempre un po’ diverso, sempre sulle sue e a disagio quando se ne parlava…tipo faceva il vago, interveniva poco, non se schierava mai…».
«Vabbè, ma che c’entra? Uno può pensa’ che non abbia il chiodo fisso e ok. Ma addirittura così diverso no, dai! Così dell’altra sponda, te l’aspettavi? Eddaje Riccardi’…così no: guarda, io non ce lo facevo proprio. Ma senti, mica l’ha saputo tuo padre? Magari l’ha sentito in giro…? No perché ‘ste cose, lo sai è n’attimo che…».
«No, no fermate, per adesso no. Gliela stiamo a tene’ nascosta…capirai se devono pure sposa’. Pora Camilla, guarda che pena…st’infame».
«E tu madre? Che dice tu madre?»
«E che deve di’? S’è fatta tre segni della croce e s’è rimessa a stende’ i panni…ma che doveva fa’ quella pora donna? Non ce se crede…dopo anni…e ce lo siamo pure portati dentro casa… ‘tacci sui»
«Assurdo…me fa schifo»
Così, quella sera, tra Lungotevere Tebaldi e Lungotevere Aventino, sul 23 era scesa una pesante cappa di silenzio.
Poi, d’improvviso, il coraggio di un uomo. Vabbè un ragazzotto in realtà: alto bene o male la metà dei due energumeni e largo quanto l’avambraccio tatuato di uno di essi.
Occhialetti da vista tondi, pashmina bordeaux e ciuffo scomposto ondulante, decide di affrontare le curate sopracciglia, in quel momento corrugate, dei tipi.
«Bestie – urla non riuscendo a trattenere la rabbia – e trogloditi! Ecco cosa siete! Ma vi rendete conto voi di quello che dite? “Me fa schifo”, “assurdo” “diverso” e “quelli come lui”.
Sapete una cosa? Siete voi che mi fate specie…e no – azzittendo con fermezza uno dei due con un movimento repentino di un dito – non cercate di interrompermi che ho ragione.
Come potete fare commenti del genere su un ragazzo che ha capito la sua vera natura? Come potete, voi, giudicarlo diverso?
Ignoranti, buzzurri e trogloditi! Ancora con questi luoghi comuni sugli omosessuali e sugli orientamenti sessuali. Che pena, mi fate!».
Così, girandosi di scatto, scende stizzito a Marmorata, continuando a bofonchiare.
«Che cazzo ha detto? » riprende uno dei due, sbigottito e mezzo imbarazzato: «Che c’entrano i froci mo’? Mica perché sei della Lazio devi esse pure frocio…e poi – sporgendosi dal finestrino per urlare in direzione del tipo ormai lontano – me stanno pure simpatici a me…- tornando a parlare con l’amico – i froci, mica i laziali!».
«Anfatti».
E soddisfatti scendono dal 23, ad Ostiense.