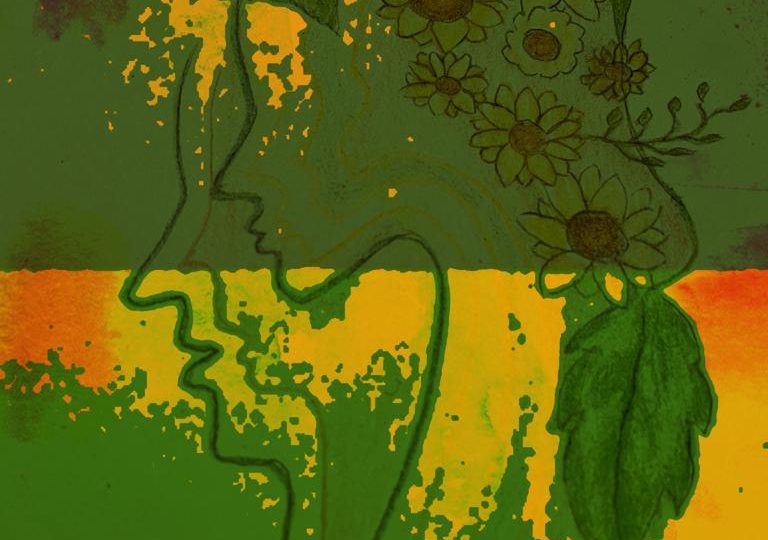di Lorenzo Tuci
Una volta in salvo sul brigantino della Serenissima, cambiatisi gli stracci sozzi e sudati con abiti da cristiani, e ben rifocillati, i cinque naufraghi furono convocati dal capitan Dandolo presso la sua sontuosa cabina, che occupava la maggior parte del cassero a poppa, lasciando due soli corridoi laterali sia ad ospitare le cabine del resto dell’equipaggio sia a schermire l’alloggio del capo dal sole infuocato o dai ceffoni degli alti marosi.
«Allora, signori,» esordì sonoramente Dandolo, stando in piedi dal retro della sua scrivania, non appena i cinque vennero introdotti, «mi è stato detto che vi siete or ora azzuffati. Dico io, proprio ora, a poche ore dall’aver scampato la morte, vi sembra opportuno tra voi venire alle mani? Mi meraviglio di voi Scarpin, che, come me, siete suddito di sua maestà il doge Silvestro Valiero! È forse questo il modo di comportarsi di un veneziano?»
Il padron giurato, addetto all’ordine della nave, che aveva accompagnato i superstiti del naufragio, intervenne: «Chiedo scusa capitano, ma il povero Gianni Scarpin non ha alzato mano, ché anzi lo abbiamo trovato sul ponte, attaccato per il bavero all’albero di trinchetto, mentre il tabarchinolo immobilizzava e il greco giùa menarlo.»
«Oh, questo poi è grave,» disse il capitano, «due forestieri, oltretutto, che attentano alla vita di un veneziano che ha appena scampato la morte, e su una nave veneziana per giunta!»
Scarpin, che ancora ansimava, era soltanto un po’ paonazzo, scomposto e gualcito sul collo del camice, ma non livido né sanguinante.
Quasi non riuscisse per l’affanno a replicare, durante e dopo le parole del padron giurato, si limitava ad annuire, con un ghigno e sfuggevoli occhiate, dirette ai colpevoli, che ne invocavano il castigo.
Dimitri il greco, detto Cleffino, pareva il più indomito.
Era l’unico a non aver voluto cambiarsi gli abiti. Aveva infatti lavato in fretta i vecchi e poi li aveva indossati ancora umidi.
Il respiro gli restava palpitante sotto la fascia rossa di fustagno che affiorava dal corpetto di pelle. Le grosse mani, che si protendevano dalle larghe maniche della camicia, strizzavano rabbiose l’aria e i lunghi baffi erano una metafora di zanne pronte a mordere.
«Gàidaros!»1 inveì contro Scarpin; poi, rivolto al capitano: «Escusi comandante, non parlo bene la vostra lingua, ma quel Gianni lì è un còiros 2! Voleva noi tutti morti di non bere.»
«In nome di nostro Signore Gesù Cristo,» intervenne il gesuita, che dal naufragio, oltre alla fede, aveva salvato anche la berretta di seta nera a tricorno che gli stava in capo, «siamo salvi! La Divina Provvidenza ci fece la grazia: permarremmo quaggiù qualche ora in più; e lor signori cosa fanno? Danno piglio alla violenza invece di rendere grazie al Cielo!».
«Insomma,» intervenne il capitano, «qui è andato a picco l’Ermagòra, un brigantino della nostra serenissima Repubblica; ci sono decine di cristiani morti e voi, come dice giustamente padre…padre?».
«Don Zenobio» suggerì il gesuita.
«Padre don Zenobio, appunto. Voi, dicevo, voi due signori, signor greco e signor tabarchino, vi accanite contro un cittadino della Serenissima, anziché gioire d’esser scampati alla morte, e mi raccontate poi di non esser riusciti a bere? Come avreste potuto bere in mare, a cavallo tutti quanti di una polena? Perché accusate costui di avervi assetati, anziché accusare il mare o l’implacabile sole d’agosto?».
«Lo spiego mi» intervenne il tabarchino «a voiotra Signoria illustre», e avanzò tenendosi nella mancina il polso destro, da cui affiorava una mano gonfia e paonazza, in contrasto col colore olivigno smorto della pelle e del capo pelato.
«Innanzitutto qual è il vostro nome?» chiese Dandolo perentorio.
«Mi chiamo Gianni, come quello là, onta della stirpe veneziana, che turco dovea nascere anziché veneziano. Gianni Canepa e son tabarchino, genovese d’Africa. Amico di Clettino, gran cuore greco, a cui detti ospitalità nella mia isola di Tabarca e che con me e gli altri qui presenti s’era imbarcato da Taranto sull’Ermagòra. Noi per altri affari, questi per raggiungere Creta e ripartir poi, dalla fortezza di Spinalonga, per guerreggiar contro il demonio turco, oppressoredi terre cristiane e predone del mare Nostru. Ma u Scarpin vostru ci volea far a tutti noitri le scarpe appunto! Ci fe’ patir ‘a sài 3! Niotri saiemu tutti morti de sài!».
«Di che?» chiese capitan Dandolo protendendo il viso verso l’ometto e corrucciando la fronte.
«Di sài, saite, insomma come si dice per farvela intendere?».
«Di sete» intervenne il giovane dalla chioma leonina, che sinora se n’era rimasto in disparte ad ascoltare attento.
«Voi sareste?» lo interrogò il capitano.
«Sono Jacopo Serrati, mercante di lane e stoffe, suddito del gran duca di terra Toscana, sua eccellenza Cosimo de’ Medici. E, se vostra signoria, data la mia spigliata favella natia e la mia pazienza nell’aver ascoltato tutto questo discorrere inconcludente, me lo concederà, vorrò raccontare per filo e per segno cos’è successo a noi sventurati nei tre giorni che passammo in mare, a cavallo di quel rudere di legno. Che sia benedetto quel bastone, scheggia del nobile brigantino Ermagòra, che cavalcammo sulle acque per tre giorni e per tre notti senza affogare».
«Ebbene ve lo concedo» gli rispose Dandolo, e poi ammonì: «E voialtri signori statevi zitti e lasciate parlare sor Jacopo».
«Io non so se il mar Ionio abbia mai visto una procella come quella, fatto sta che a poche ore dall’aver mollato gli ormeggi, sopraggiunta la notte, un vento titano e onde che si confondevano con montagne rovesciarono l’Ermagòra, che per cause oscure aveva iniziato a imbarcare acqua dalla chiglia.
Noi cinque, visto l’inabissarsi della nave, per non fare la fine dei topi in trappola, ci eravamo portati fuori, sul ponte, ma, per non essere sbalzati in mare, ci tenevamo abbarbicati agli alberi – chi a quello di mezzana, chi a quello di maestra e io a quello di trinchetto. La pioggia non solo cadeva su di noi, ci frustava, mentre le folgori scandivano i secondi che accompagnavano lo sprofondare di quel legno negli abissi. A un certo punto io vidi un lampo abbattersi sulla prua, a poca distanza da me. Poco dopo il brigantino iniziò a imbarcare acqua anche da là, sul davanti, dove la saetta gli aveva tagliato il muso. Prima che la nave venisse sommersa, mollai il mio palo e, per un tempo che mi parve interminabile, venni sciabordato come un burattino da quelle acque infernali, cercando soltanto di riprendere fiato non appena io potessi cacciare la testa fuori dall’onda. Quando il mare si acquietò, alla flebile luce delle stelle che tornarono a far capolino, vidi a poche bracciate da me sor Canepa tabarchino e il greco Cleffino avvinghiati al solo legno che dell’Ermagòra fosse rimasto a galla. Li raggiunsi, senza che inizialmente se ne accorgessero. Quando mi issai a cavalcioni su quel legno, lo fecero anche loro, e di lì a poco recuperammo a pelo d’acqua anche i corpi di don Zenobio e di messer Scarpin, che poi scoprimmo essere ancora vivi.
Arrivò l’aurora e, dal conoscerci solo di vista, passammo a raccontarci chi fossimo, mentre tutti e cinque ci trovavamo a cavallo di quella che era stata la polena del brigantino: un solido tronco conico la cui cima, un imponente leone alato di san Marco, era passato dal fendere il vento, indicando la rotta, a dare ospizio a cinque morituri,portandoseli a dorso. Prossimo al podice della belva argentata, sedeva messer Scarpin, dietro a lui don Zenobio gesuita, dietro a questi stavo io e, dietro a me, sor Canepa e infine il greco guerrigliero. Data la precarietà della nostra scialuppa, era difficile cambiare postura. Le gambe poi, dal ginocchio in giù, dovevamo lasciarle quasi tutto il tempo in ammollo, così come il leone veneto immergeva zampe e Vangelo, mentre sulle nostre teste, anche se coperte con stracci o cappelli, martellava, nelle ore pomeridiane, la rivalsa del sole sulla passata tempesta.
Il primo giorno e la prima notte, su quella bizzarra cavalcatura, passarono per noi sì con fastidio, ma non ancora con tormento. Il secondo giorno però, le cose cambiarono. Già dal mattino, avendo dormito pochissimo, per la paura che quell’abisso là sotto potesse essere il nostro anonimo sarcofago, ci sentivamo stanchi e ormai indolenti, anche a discorrere tra di noi. L’unica voce inarrestabile era quella di don Zenobio, che continuava a salmodiare e a sfogliare le paginette fradice e increspate del suo breviario.
Ben presto iniziammo a lamentarci per la fame e poi per la sete. La fame, dopo averci fatto mugolare i visceri, con la fierezza del Re di Franciaa cui si diserti un abboccamento, se n’andò sdegnata; ma la sete… quella no! con la tenacia d’un usuraio giudìo, presentava irriducibile il conto. Allora io dissi agli altri che, benché ciò potesse solo prolungare la nostra agonia prima della fine, a tracolla avevo una bisaccia piena del vin leggero delle mie vigne, che ero aduso a portare sempre meco viaggiando. Ne avrei lasciato sorseggiare a ciascuno giusto la quantità contenuta dal palmo concavo della sua mano.
E così tutti ne avemmo un sorso, che poco poco ci ristorò.
Giunse la notte e, vinti dalla stanchezza, riuscimmo un po’ a dormire, ciascuno caduto prono sul dorso di chi gli stava davanti e sor Scarpin sulla schiena del leone. Quando fu giorno, sempre con davanti quel deserto d’acqua e cielo, fame e sete tornarono ad affliggerci. Prima che qualcuno me lo chiedesse, sul volgere del mezzogiorno, offrii di nuovo, ai naufraghi compagni,il vino nel palmo, come la sera prima. E dopo che lo avemmo trincato, don Zenobio si rivolse a sor Scarpin in un modo che lasciò tutti perplessi.
Gli disse infatti: “Perché non vi conducete anche voi come messer Jacopo e dividete con gli altri ciò che avete?”
“E cosa g’ho mi più de voaltri? Furse la fam o la sete?” rispose il veneziano.
“Vi ho visto, sapete!?” replicò lesto il sacerdote, “Quando ancora non era giorno, voi stavate mangiando. Esurivi enim, et dedisti mihi manducare…” 4 “Sitivi et dedisti mihi bibere 5, com’ho fatto io con tutti voi” completai io la citazione evangelica.
“Appunto,” proseguì don Zenobio, che si era brevemente voltato con approvazione verso di me, felice di avere in simili circostanze un compagno di favella latina, “fate come recita il Vangelo di Matteo,” riprese in direzione di Scarpin,“dividete con tutti da buon cristiano e Dio ve ne renderà grazia, ché forse presto sarete al Suo cospetto”.
A queste parole, avvertii i due dietro di me agitarsi e presto passare a rivolgere contumelie contro costui che nascondeva il desinare. Dopo aver per un po’ sgomitato nel tentativo di allontanare le mani del tabarchino e del greco, che cercavano di strattonarlo passando sopra le spalle mie e di don Zenobio, mentre noi, dal canto nostro, cercavamo di riportarli a più miti consigli, sor Scarpin gridò: “Xiti! Fermi! Scolte’!” 6 e, acquietando gli animi con questo annuncio di un discorso incipiente, si distese poggiando il fianco sinistro sul dorso del leone per vedere tutti meglio con quella postura. Poi riprese: “G’ho co mi dea carne salada, ma no vea darò miga in cambio degnente. Mi so’ un mercante e so che el mondo pende da un piato de stadera. Tanto qua morimo tuti, e mi vojo morir mbriago, par patir de manco” 7 e rivolgendosi a me disse: “Se ti, toscan, te me dà el vin avansà, mi te do ‘a carne salada” 8.
Al che, io non sapevo davvero cosa rispondere.
I miei due compagni a tergo mi dicevano di non barattare; don Zenobio spostava lo sguardo da me a Scarpine riprese a salmodiare: “Domine Deus, amo Te super omnia et proximum meum propter Te…” 9
Dopo molto indugio, non fui io a decidermi, ma il veneziano a farmi una nuova proposta: “Ti, se te gheun fiorin de oro, ‘a monea toscana, ‘a metemo qua drento” e mostrò un piccolo fagotto di pelle chiudibile con una cordicella, “e ghe metemo anca na bea lira venexiana. Dopo te tiri su e…la moneda chea vien su la xe el voler de Gesù: si te tiri fora el fiorin te dago ‘a carne, coa lira teme de’ el vin.”10
Io, che di cibo non ne avevo quasi punto, ma di fiorini un po’ di più, accettai, e porsi a sor Scarpin la mia bella moneta d’oro, che risaltava accanto alla lira argentata, ma spenta dall’ossido, ch’egli mostrava tra le dita,voltatosi verso di noi. Preso ch’ebbe il mio fiorino, tornò a darci le spalle e appoggiò la bisaccia sul dorso del leone. Poi fece vista di aprirla e di mettervi le due diverse monete. Nel frattempo, don Zenobio si era sporto di sottecchi sopra le spalle del nostro amante della sorte e, riabbassatosi subito, si era messo a recitare ad alta voce, voltato a guardarmi, un salmo latino che giammai avevo sentito, né in Santa Maria del Fiore né in Santo Spirito oltrarno, né scritto sui Vangeli né in bocca di predicatore: “Fuscos tantum nummos in culleo posuit!”, ossia nel sacco ci ha messo solo monete scure.
E io, compreso dal messaggio in codiceavere lo Scarpin riposto solo ducati nella bisaccia, risposi,pur’io nell’antica favella, salmodiando: “Ora pro nobis ac ne hoc impedìeris!”11.
Così, quando Scarpin mi porse la sacca da cui estrarre la moneta, sotto lo sguardo sbigottito del nostro curato, io, facendo finta di niente, v’infilai la mano ed estrassi; ma, prima che si potesse vedere cosa avessi tirato su, mi feci cadere il metallo di mano lasciando che si perdesse negli abissi.
“La ghera ‘na lira, la g’ho vista!” 12 disse subito Scarpin, ma io lo contradii subito: “No, era un fiorino, era d’oro!”.
Sennonché, lesto come un fulmine, don Zenobio gli strappo la bisaccia dalla mano e disse: “Non è difficile sapere cosa ha estratto sor Serrati, basterà guardare cosa c’è rimasto qui dentro”. E così, signor Capitano, chi ci voleva far passare da bischeri, mettendo due lire in saccoccia e il mio fiorino nelle mutande, bischero fu».
Gli sguardi dei salvati e dei marinai presenti puntavano tutti dritti come sciabole sguainate verso il volto del mercante, che, in cerca di qualcosa da dire, dissentiva oscillando il capo.
«Siete un’onta per la Città che vi diede i natali!» affermò Dandolo, «avete comunque salvata la vita, ma non fate ch’io vi incontri di nuovo, né per mare né per terra».
E poi, sottovoce, «Slandron da ciapar a peae intel dadrìo!»13
[1] Lett. “asino”
[2] Lett. “maiale”
[3] Lett. “sete”
[4] Vangelo secondo Matteo 25.35: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”
[5] Ibidem: “Avevo sete e mi avete dato da bere”
[6] “Zitti, fermi, ascoltate!”
[7] “Ho con me della carne secca, ma non ve la darò certo in cambio di niente. Sono un mercante e so che il mondo pende da un piatto di stadera (antica bilancia portatile usata dai mercanti N.d.A.) Tanto qua moriremo tutti, e io voglio morire ubriaco, per patir meno”
[8] “Se tu, o toscano, mi dai il vino rimanente, io ti do la carne secca”
[9] Dalla preghiera cattolica Atto di carità: “O Signore, ti amo sopra ogni cosa e il mio prossimo accanto a te”
[10] “Se hai un fiorino d’oro, la moneta toscana, la mettiamo qua dentro, e ci mettiamo anche una bella lira veneziana. Dopo tu estrai e… la moneta che ne esce è il volere di Gesù. Se tiri fuori il fiorino ti darò la carne, con la lira tu mi dai il vino”
[11] “Prega per noi e non fermarlo”
[12] “Era una lira, l’ho vista!”
[13] “Lazzarone da prendere a calci nel deretano!”