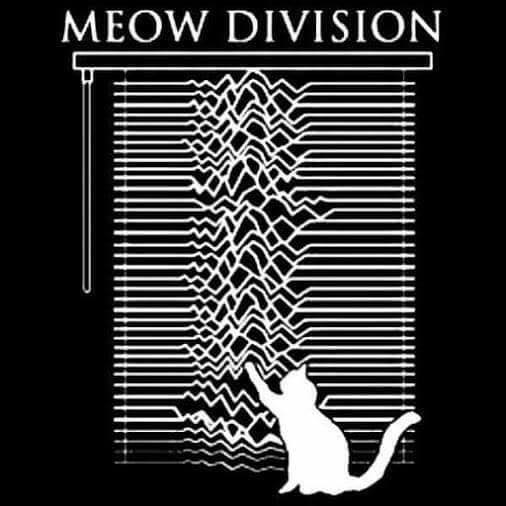di Matteuccia Francisci
Illustrazione di Anastasia Coppola
«Questo è uno dei segreti del Turco»,
mi disse guardando verso il famedio del PCI.
Andavo sempre a farmi una passeggiata al Verano quando mi sentivo inquieta senza un motivo apparente.
Prendevo il 71 a Via Nazionale perché mi piaceva passare per le vie con i nomi di tutti quelli che avevo studiato pensando che la politica italiana fosse una cosa seria, e parlarci mentalmente chiedendo a loro in cosa avessero sbagliato. Perché qualcosa, gli dicevo, dovete avere sbagliato se adesso ci ritroviamo in questo teatrino di pupari. O eravate marionette anche voi, anche allora?
Il tempo di farmi queste domande inutili e mi ritrovavo all’ entrata principale, guardavo verso la statua del Silenzio e, come obbedendole, smettevo di fare domande. Di solito mi sedevo in un posto a caso e aspettavo.
A volte uno di loro veniva a trovarmi.
«Come fate a sapere chi di noi saprà tenere il segreto?» gli avevo chiesto, e lui mi aveva risposto che quello, a sua volta, era un altro segreto.
Il segreto del Turco.
Fu così che conobbi la storia del Turco.
Il Turco era arrivato a Roma quando le cose si erano messe male per lui, a Istanbul. Roba di femmine, pare, ma i più sospettavano ci fossero di mezzo i servizi segreti e il loro coinvolgimento in Bulgaria negli anni ’50. Qualcuno diceva fosse un lontano discendente addirittura di Ataturk, qualcun altro che fosse solo un volgare spacciatore. Qualsiasi fosse la verità, tutti abbassavano la testa quando passava lui, e molti giravano al largo. Ma tutti, proprio tutti, ascoltavano le sue storie.
«Erano le storie migliori che avessimo mai sentite. Si sedeva al sole, si accendeva una sigaretta e cominciava con un “Mi ricordo quando ero a Istanbul…”. Piano piano arrivavamo da tutte le parti, nessuno voleva perdersi una storia del Turco».
«Come sarebbe, che si accendeva una sigaretta?» chiesi un po’ perplessa al mio interlocutore. Mi guardò come se avessi chiesto cosa volesse dire che c’era il sole.
«Fumava. E tanto. Sennò che turco sarebbe stato?»
«Ma…»provai ad obiettare, ma venni zittita da un perentorio «Non interrompermi con queste sciocche domande, la vuoi sapere la storia del Turco o no?»
Adesso che mi aveva detto che fumava la volevo sapere eccome.
Il Turco conosceva tutti quelli che contavano davvero a Istanbul.
Non quelli che tutti pensano contare, cioè, ma gli altri, quelli che nessuno conosce e che possono assicurarti la migliore delle vite possibili.
«E chi sono costoro?» chiesi davvero curiosa di sapere chi potesse assicurare loro la vita migliore.
«Macellai, pescivendoli, giornalai, portieri d’albergo, ricche signore sole, fiorai, farmacisti, proprietari di bar e ristoranti, ma anche di tintorie ed elettrodomestici. E pasticcieri. Il Turco conosceva tutti i migliori pasticcieri di Istanbul».
Non riuscivo proprio a capire cosa se ne potesse fare di farmacisti e proprietari di tintorie, ma venni liquidata con uno sguardo severo al solo provare ad aprire bocca.
Fu proprio un pasticciere che lo aiutò nella sfortunata storia di Afet, bellissima e amata dal Turco fin dal primo loro incontro in Piazza Sultanahmet, dove il Turco andava ogni giorno in cerca di notizie fresche, così diceva. Rimasta orfana in giovanissima età, Afet non si era mai legata a nessuno ed era sempre riuscita a sfuggire con astuzia ai tentativi dei suoi spasimanti di farla loro. Diffidente e altezzosa, rifiutò anche le lusinghe del Turco e rispondeva con piccoli sbuffi di impazienza ai suoi goffi tentativi di farla ridere.
«Eppure le barzellette del Turco erano le più spassose, aveva un modo di raccontarle che da solo bastava a farti ridere», ci tenne a precisare il mio nuovo amico.
La bella Afet sembrava proprio non avere alcun interesse per il Turco. Allora lui decise di seguirla, per capire dove andasse e cosa le piacesse.
Le avrebbe dato tutto ciò che lei desiderava, e anche quello che non sapeva di desiderare. Quando il Turco si metteva una cosa in testa, non si fermava finché non la otteneva.
“Non esiste nulla che non si possa prendere, è solo questione di quanto veloce sai correre” era la sua massima preferita.
Scoprì che Afet andava pazza per l’aşure, che consumava con voluttà una volta a settimana, da sola, nei giardini del Topkapi.
La fortuna o gli dèi vollero che il proprietario della pasticceria in cui si riforniva Afet fosse uno dei migliori amici del Turco.
Le fece trovare ciotole piene di aşure al Topkapi tutti i mercoledì, sotto al suo albero preferito, con un biglietto recante una sola parola: salvami.
Da cosa lo dovesse salvare, Afet non lo seppe mai, ma alla fine capitolò più per la curiosità di sapere chi fosse il suo misterioso benefattore, che per il gesto in sé. Continuò sempre a dimostrare una certa noncuranza nei confronti del Turco, ma da quel giorno non si separò mai più da lui.
Il Turco, dal canto suo, non faceva altro che pensare a come sorprenderla, blandirla, deliziarla. Organizzava banchetti da mille e una notte per lei, e faceva arrivare le migliori stoffe da Parigi per la sua amata, che andava a prendere di persona al porto per poi correre a potergliele di persona. Non di rado se le vide rifiutare con una sola, piccola ma inequivocabile arricciata di naso, e allora il Turco tornava al porto a sbraitare col mercante che “Quegli stracci se le mettessero le parigine, a Istanbul abbiamo gusti sopraffini, la mia Afet vuole solo roba di prima scelta!”
E poi un giorno non la trovò più.
Sparita, volatilizzata, Afet non era in nessuno dei posti che era solita frequentare e a casa non fece ritorno.
L’aspettò, il Turco, per un mese intero, sotto casa, rimase ad attendere che tornasse. Lo si vedeva sotto il sole cocente ad ansimare dal caldo e zuppo come un pulcino sotto la pioggia. Fermo, immobile, sotto la sua finestra. Afet non tornò mai più, qualcuno disse che era stata investita da un tram e poiché non aveva parenti era stata seppellita alla svelta senza tante storie.
Da allora il Turco cominciò a odiare Istanbul e a pensare di partire, andare in un luogo che non gli ricordasse la sua amata. Non Parigi, delle cui sete la ricopriva, né Londra, da cui faceva venire le rose più profumate per lei. Roma, sede di antiche divinità, gli sembrò una buona scelta.
Avrebbe chiesto loro di intercedere per fargliela rincontrare, se non in questa almeno nell’altra vita. Non si decideva mai a partire però, e fu soltanto quando incontrò il contrabbandiere di piume che infine si risolse.
«Il contrabbandiere di…piume?» chiesi asciugandomi una mezza lacrimuccia che la storia del Turco e Afet mi aveva fatto scendere.
«Che fai, piangi?» mi chiese lui.
«No, no, sono un po’ allergica» mentii, girando un po’ la faccia perché non vedesse che me ne stava scendendo un’altra. «Ma cos’è un contrabbandiere di piume?» chiesi di nuovo.
«Eh, quella è un’altra storia e io adesso devo proprio andare. Mi aspettano per la cena».
«Ma sono solo le cinque».
«Sta tramontando, e anche tu devi andare, fra poco il cimitero chiude. Mi ha fatto piacere conoscerti, se tornerai forse ti racconterò la storia del Turco e del contrabbandiere di piume, e di come il Turco stava per perderci un occhio. Ciao!»
Non feci in tempo e dire neanche ciao che già se n’era andato, veloce e silenzioso com’era venuto.
Sulla coscia, mi accorsi, aveva lasciato una piuma.
Bianca e nera, piccola piccola. Chissà dove l’aveva presa, non volevo saperlo, me la passai sotto al naso per farmi il solletico.
Mentre ridacchiavo, mi sentiti chiamare da una signora.
«Le ha lasciato una piuma?» mi chiese avvicinandosi.
«Credo di sì, non lo so, me la sono trovata addosso».
«Lo fa con tutti quelli che gli piacciono, per questo lo chiamiamo anche Piumino. Il Turco è un grande cacciatore, ahinoi, di uccellini».
«Come, il Turco? È lui il Turco?».
«Sì, lo abbiamo trovato a Piazzale Ankara da piccolo. Era stato investito e le mosche carnarie stavano già riempiendo la sua ferita all’occhio. Pensavamo lo avrebbe perso e invece si è salvato.
Per questo e per la sua passione per le sigarette, al gattile lo chiamiamo il Turco».
«Le fuma?» chiesi, ormai in piena confusione.
La donna scoppiò a ridere:
«Ahahah, no no! Ne abbiamo viste di tutti i colori, ma un gatto che fuma ancora non lo abbiamo visto. Gli piace giocarci, appena vede un pacchetto di sigarette, cerca di aprirlo e tirarne fuori una. Bisogna pure stare attenti, una volta se la stava quasi mangiando, e il tabacco è super tossico per loro».
Come no, mangiarla, pensai.
Quel furbacchione se la voleva fumare, altroché. Guardai la mia piumetta e me la passai delicatamente su una guancia, poi la riposi nel portamonete. Salutai la signora e le dissi di non dire al Turco che mi aveva vista.
«Certo che no, cerchiamo di lasciargli la loro vita segreta» mi disse lei, come se la nostra fosse la conversazione più normale del mondo e non una totale follia.
Il segreto del Turco, dunque, era che solo lui sapeva chi avrebbe saputo tenere il segreto del Turco. Chissà se avrebbe portato anche a me un regalo diverso per ogni volta che ci fossimo incontrati, come aveva fatto con Afet, mi dissi.
Mentre passavo sotto Silenzio, la guardai e mi avvicinai il dito indice alle labbra, e sorrisi come mai avevo fatto prima d’allora.
Presi il cellulare e digitai “pasticcerie arabe a Roma”.
Mi era venuta una gran voglia di aşure.