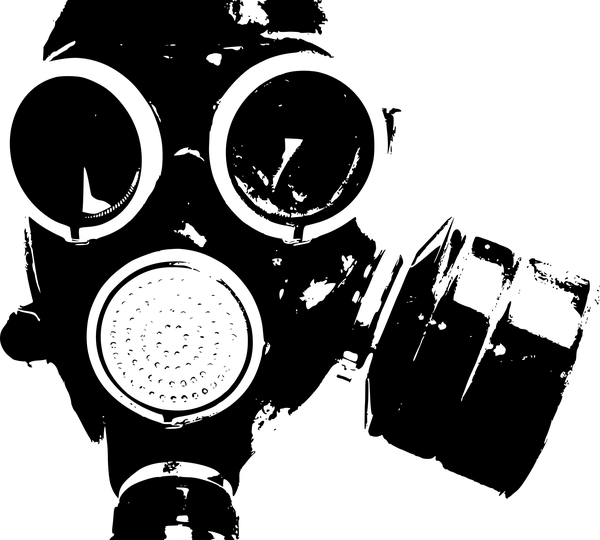Satif, destinazione Nomentana
di
Arundo Donald
Capitolo quinto. Avanti tutta
La deflagrazione sarebbe stata da film.
Tutti i vetri dell’autobus sarebbero esplosi creando un effetto fontana con schegge sparate ovunque lontano. Il mezzo si sarebbe sollevato da terra di un metro buono, per poi ricadere producendo un tonfo sordo e metallico. Il quartiere intero sarebbe stato destato. Il mondo, finalmente libero.
Satif era a cavallo. Non mancava ormai molto perché il piano entrasse nel vivo dell’azione.
Conan aveva riempito la tanica con la benzina. A portarla era Andre nel suo Invicta Jolly arancione e giallo.
«Potevi scegliere uno zaino più visibile» disse Viky sfottendolo.
«Pensa a te, femminuccia!» rispose Andre ghignando e continuando a camminare.
La trovava carina quanto insopportabile. Aveva dei bei seni alti e delle gambe lunghe e veloci, proprio come la sua linguaccia. Vestiva in maniera poco appariscente, ma si vedeva che aveva gusto. Insomma, ad Andre Viky non dispiaceva. Fisicamente, s’intende.
Satif si spostava velocemente verso la Nomentana attraversando le miti viette del Trieste Salario. Deciso e irrefrenabile, contava di raggiugere la fermata del 60 perfettamente in orario per le 10 e 30 circa.
Cinque fermate, due ville, sei semafori e circa 15 ambasciate più in là, sempre sulla Nomentana, Tiziano Farro era intento a fare colazione nel solito bar sotto casa.
«Ciao, Samantha, sei divina oggi! Che ci stanno i cornetti integrali alla pappa reale e cuore di lampone?»
Come sempre quando andava a incidere, faceva colazione, comprava qualche fresia dal fioraio romeno e poi prendeva l’autobus alla fermata d’angolo di viale Regina Margherita.
La Nomentana, a breve, sarebbe diventata un teatro di guerra.
A morte il trash, a morte i Viet Cong!
Franci nel frattempo era riemerso dal casinò senza fiches, ma con in mano una busta di mele. Ne addentava una camminando spedito verso la fermata più vicina. L’appuntamento con Ida era in centro. In un posto chiamato non ricordava neanche come. Poi sarebbero andati alla mostra di quel matto di Karlos.
Era felice di vederla e anche un po’ agitato. Non era molto che si frequentavano. Dopo l’incontro a Ostia, erano passate poche settimane durante le quali, se non si vedevano a casa di lei, andavano sempre a cena o al cinema. Ma anche a fare colazione e alle mostre.
Ida, dopo l’avventura consumata a casa dell’ex marito, era turbata. Avrebbe avuto voglia di dormire qualche ora, ma non poteva. Alle 11 e 30 aveva appuntamento con Franci al Caffè delle Arti in via Nazionale per una colazione veloce. Poi sarebbero andati alla mostra di Karlos Marranos, un fotografo brasiliano amico di Franci che viveva a Frosinone, dove aveva fondato una ONLUS che mandava soldi ai bambini delle favelas.
Lei che non usciva mai dai Parioli. Che adorava andare alle cene e agli aperitivi nei posti rinomati. Che odiava il diverso, storceva il naso, amava essere viziata e non le era mai fregato un cazzo delle stupide mostre da radical chic.
Pensò di essersi bevuta il cervello! Erano settimane ormai che si frequentava con uno che neanche poteva permettersi di pagarle una cena decente.
Uno che andava in giro come Jim Morrison nel periodo alcool e cocaina e che porcaputtana… la faceva impazzire.
Sì, si era proprio rincoglionita!
«Avanti tutta» disse Viky per spronare la squadra.
Ormai mancava veramente poco alla Nomentana. Erano circa tre chilometri buoni che camminavano e la stanchezza si faceva sentire. Lo zaino pesava.
«Ma non possiamo fare un po’ a cambio?» sbottò Andre scocciato.
«No» risposero in coro gli altri.
«Ma scusate, che senso ha? Che cazzo sarebbe la MIA missione?»
«No. Sarebbe che così è stato DECISO e così si va AVANTI e a tutta forza! Non si cambia un piano quando è bello che fatto. Si rispetta!»
Andre neanche rispose.
La odiava. Odiava quello zaino e odiava i suoi modi autoritari.
«AVANTI TUTTA!!» gridò Viky.