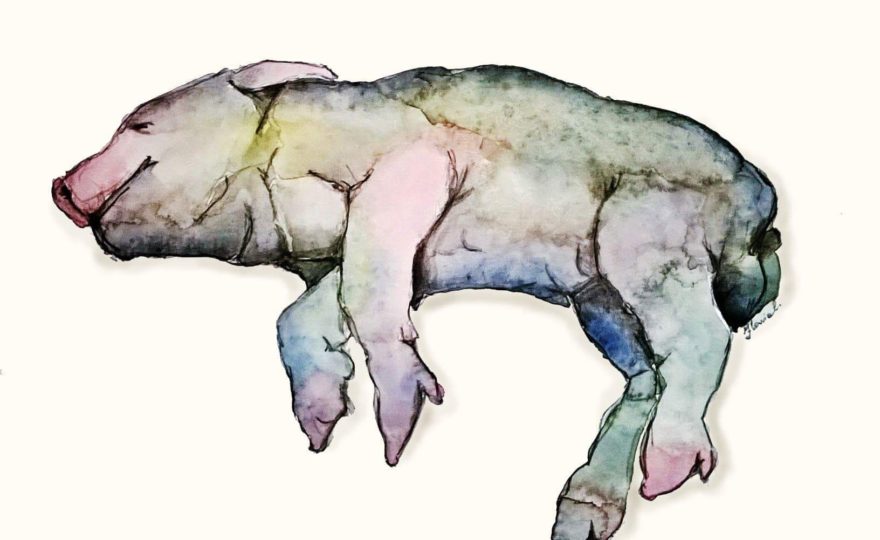di
Federico Cirillo
Illustrazione di Ponz
– Siamo tutti ordinari. Siamo tutti noiosi. Siamo tutti spettacolari. Siamo tutti timidi. Siamo tutti in grassetto. Siamo tutti eroi. Siamo tutti impotenti. Dipende solo dal giorno.
«Ora ci credi. Ora è il momento. Non c’è più tempo, quasi…». Queste ultime parole escono dalla bocca e dai pensieri di Alfred con un tono totalmente diverso da quello usato per il racconto: serio e solenne, mentre scambia uno sguardo d’intesa con Batman, sul cui volto ora è scomparsa anche quell’ombra amara di solitudine che lo accompagnava sempre nei nostri ultimi “incontri”. Sono lì entrambi, uno avanti e uno dietro, più veri e tangibili che mai. Batman mi guarda, in silenzio, e noto che in mano ha qualcosa… qualcosa per me? Un fagotto di carta. Giornali avvolti tra di loro. Giornali e riviste che riportano le notizie e i titoli delle sue azioni leggendarie. Articoli che parlano di lui e lo ritraggono in compagnia del suo fido alleato, del suo compagno di venture e sventure. Il classico simbolo del pipistrello al centro del torace di lui, un cerchio nero con una R gialla sul petto dell’altro, più giovane.
L’altro. Il ragazzo. R. Robin.
«Aprilo, Ragazzo, guarda dentro» mi fa Alfred con un sorriso sornione, accennando due passi indietro. Strappo via la carta, di fretta e senza pensare. Il 766 corre e non fa più fermate adesso. O forse le fa, ma non importa: tutto vortica attorno a me. Batman, Alfred, il Jocker, la folla che è ormai solo un ammasso di sagome. Il 766, il ragazzo con la vitiligine, il Batman vecchio, stanco e derelitto. La donna dagli occhi da gatto, “e dire che allora”: tutto ruota veloce e si ferma sull’oggetto all’interno del pacco: un costume. Rosso, maniche verdi come i guanti regalatimi la volta scorsa, un mantello giallo con la R cucita sul petto.
Una volta aperto l’involucro, dall’interno cade svolazzando un altro foglio di giornale: “Continuano i furti di Testa di Demone. Chi è il pericoloso terrorista che si cela dietro quel satanico simbolo? Siamo sull’orlo di una guerra batteriologica?”. Questo il titolo che campeggia centrale. Impietrito e sconnesso, sento solo una mano che si appoggia sulla mia spalla.
«Bentornato, ragazzo. Bentornato, Robin» mi fa, e all’istante mi si gela il sangue. Vorrei dire tanto, vorrei chiedere tutto e chiedermi mille perché.
«Tocca a me, Batman?» esce invece, quasi meccanicamente, dalla mia bocca.
«Tocca a noi. Scendiamo, la macchina è parcheggiata a Grotta Perfetta.»
Mentre indosso la maschera, la blusa e il mantello, Batman mi guarda, braccia incrociate e sorriso sicuro. «Lo fermiamo?» domando. «Ricordi come si fa?» mi chiede. Sorrido e scendo al volo dal finestrino aperto (non chiedetemi come diavolo abbia fatto, ma so farlo, me lo ricordo!). Scende anche Batman, scuotendo la testa tra un sorriso e un’occhiataccia.
«Signore!» urla Alfred da dietro, rincorrendoci e reggendosi il cappello da perfetto omino inglese, «difficile che riusciate a guidare senza queste…» e ci lancia le chiavi.
«Vecchio Alfred – fa Batman voltandosi e afferrandole al volo – senza di te, mi scorderei tutto, anche il passato.»
Fine.