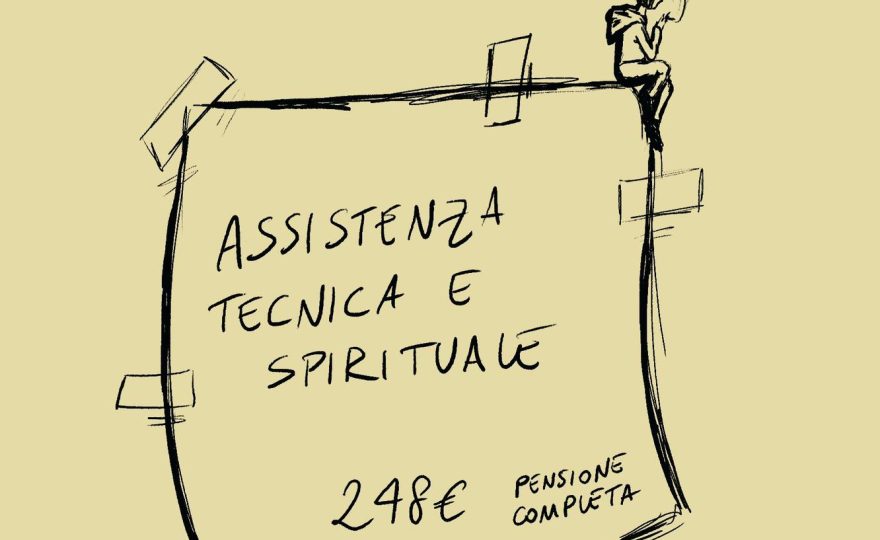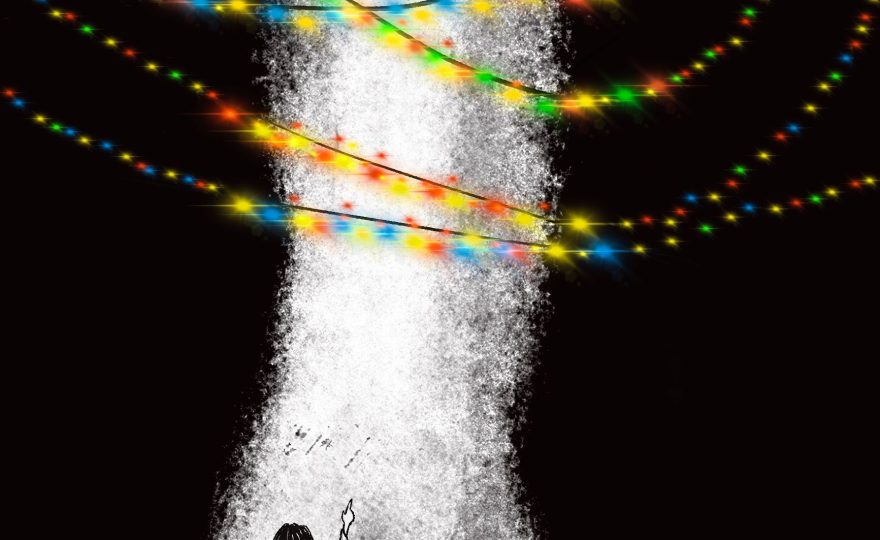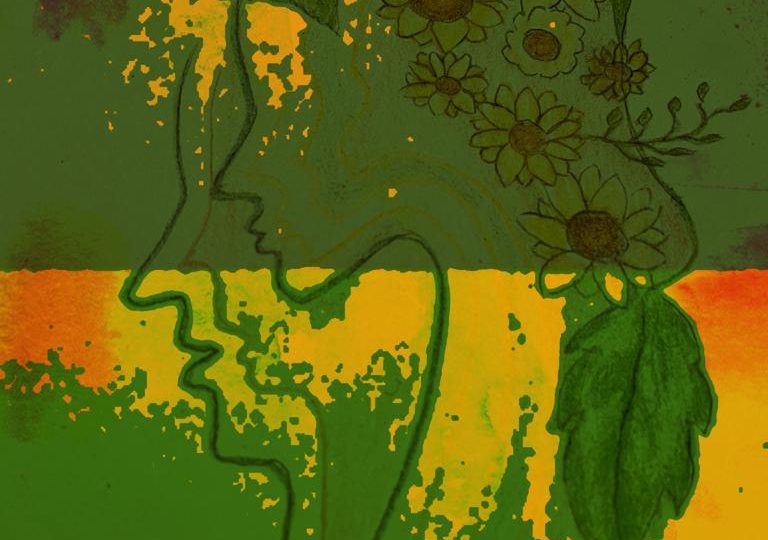di Rachele Fattore
Illustrazione di Anastasia Coppola
Pubblicato per NN Editore nel 2018, Il diner nel deserto è un avvincente noir on the road.
Avvertimento: l’itinerario di un camionista è presumibilmente noioso e ripetitivo.
Ma se non si è mai saliti a bordo di un autoarticolato, questa è l’occasione giusta per rivalutare la cosa.
A patto di essere disposti a tutto e di essere consapevoli che, forse, una stagione sulla Route 117, in pieno deserto, potrebbe non bastare…
Prendete una road map e se non trovate la strada non fermatevi, non fate domande e, soprattutto, non bussate a Walt.
Dallo svincolo della US- 191 a Rockmuse, la State Route 117 si allontana calda e inospitale nel mezzo del deserto dello Utah per svariati chilometri. Proprio lungo quella lingua di asfalto e polvere rossa Ben, camionista indebitato fino al collo, lavora ogni mattina per portare avanti la fallimentare Ben’s Desert Moon Delivery Service, facendo piccole consegne. Attratto da quella sensazione di sentirsi a casa e consapevole che laggiù tutto di disgrega, Ben è anche l’unica persona della quale i pochi abitanti del posto si fidino veramente. Un saluto veloce, un rapido cenno del capo. La conversazione è ridotta al minimo, come gocce d’acqua che valgono una vita: è il silenzio a raccontare storie impossibili da scordare.
Ogni personaggio è immerso in un’aura di solitudine: quella che spinge un ragazzino abbandonato alla nascita, dal sangue mezzo indiano e mezzo ebreo, a pedalare nel deserto per sentire riecheggiare tra le gole la sua cornamusa; quella di Walt, vecchio marine che aggiusta moto in un Quonset dietro al suo diner vintage chiuso ormai da trent’anni; quella di una ragazzina incinta tradita dalla madre ma fedele all’amicizia col suo ex; quella dei due fratelli che abitano nelle carrozze di un vecchio treno.
Sono figure evanescenti e spettrali dal fascino seducente e mortale. Personaggi ruvidi, temprati dalla sabbia e da una vita che prima o poi chiede il conto, statue di fango arse dal sole nelle quali si agitano gli spiriti dei ricordi.
La dama di picche con gli stivali da cowboy
La svolta all’apparente monotonia delle consegne giornaliere giunge con l’arrivo di Claire. Lei è la carta che spariglia l’intero mazzo. Un’apparizione danzante in una casa apparentemente abbandonata: Ben la vede per caso, mentre suona una musica che pochi possono sentire. Sembra un sogno ma non è così: Ben e Walt si fanno impossessare da un sentimento che sembra dar loro una nuova vita, ma un presente è a malapena l’unica cosa in cui si può credere.
Basta giusto una fessura del cuore ed ecco che il deserto libera i suoi peggiori spettri.
Non tutto ha una spiegazione e non sempre è una buona cosa cercarne una, soprattutto in luoghi inospitali dove le persone si annidano per scelta o per necessità.
Le condanne rimangono e sono quelle delle scelte fatte delle quali il tempo, presto o tardi, chiede il conto. Ognuno ricerca nell’isolamento la propria salvezza; sono però i canyon dell’animo umano quelli più insidiosi, e la natura aspra nella quale le vicende narrate si inseriscono ne è in parte specchio, in parte giudice al di sopra di ogni giustizia.
Non era il paradiso e non era l’inferno, solo un rettilineo che ci passava in mezzo.
Il deserto, vero e proprio santuario delle anime perse, non si limita ad essere uno sfondo ma è un vero protagonista. Un’entità naturale silenziosa quanto potente governata da leggi inaccessibili: buoni o cattivi non fa nessuna differenza.
La natura si allarga a dismisura, rivendica la sua purezza, mentre le questioni umane diventano sempre più piccole e insignificanti. Sperare nella forza rigenerativa della pioggia è un grosso errore di valutazione: quando si avverte l’odore acre nell’aria polverosa, è meglio mettersi al riparo e anche in fretta perché il deserto alla fine si prende sempre ciò che vuole.