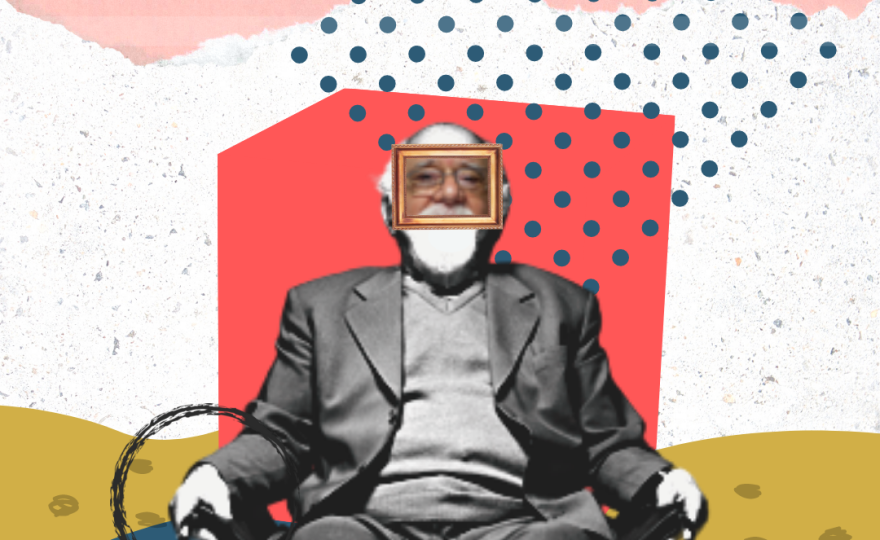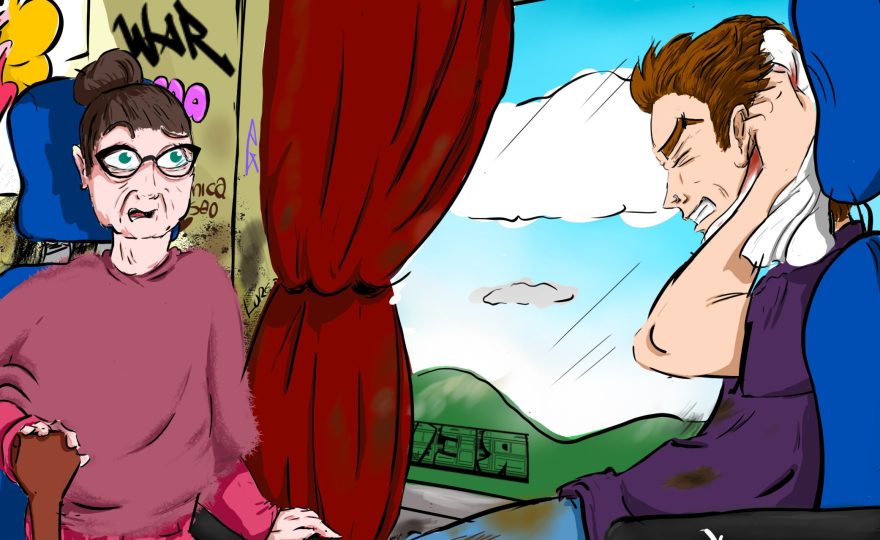di Rachele Fattore
Illustrazione di Anastasia Coppola
Romanzo del 2019 pubblicato da Keller, “Quasi tutto velocissimo” è un on the road in cui i due personaggi vestono i panni di presente e futuro, dialogando tra loro alla ricerca di un intreccio esistenziale.
Quante dita ti restano prima di morire?
Il tempo scorre in una clessidra senza speranze di ribaltamento. Il responso del medico è chiaro: cinque dita di una mano; cinque dita che potrebbero essere abbastanza ma non per Albert e Fred.
Albert è un orfano di diciannove anni che fin dal primo momento tenta la fuga dall’orfanotrofio rintanandosi da quello che gli dicono essere suo padre. Il sessantenne Fred è un bambino intrappolato nel corpo di un adulto che passa le sue giornate a contare le macchine verdi alla fermata dell’autobus. Non è sempre facile gestire il ribaltamento di ruoli, ma Albert si aggrappa a Fred perché è il suo unico legame con quel passato a cui vuole dare un nome.
L’uno arrendevole, l’altro testardo si uniscono nella ricerca di indizi in un viaggio tutt’altro che scontato.
Quanti tesori nascondiamo nel vano porta oggetti delle nostre auto?
Un calendario dove annotare il numero di mezzi verdi, una vecchia audiocassetta che produce un fruscio incomprensibile, una scatola di latta con una pepita d’oro.
Chi di noi non conserva oggetti quasi insignificanti che nascondono storie intricate, dolorose e tenere al contempo. Sono briciole di Hänsel. Ma abbiamo sempre il coraggio di seguirle?
Attenti a non tirare lo sciacquone.
Una vasca da bagno piena di acqua gelida all’improvviso diventa, aggiunto un po’ di sale, l’Oceano Pacifico. Un oceano dove immergersi con una tuta da palombaro ereditata da un padre scomparso prematuramente, forse nelle tubature sul fondo dell’Oceano, dentro alle quali magari continua a vagare per gli Stati del mondo.
Come non provare un senso di schifo davanti all’immagine delle condotte fognarie di una città. Eppure, tra le pagine di questo romanzo, si arriva al punto di crederle il posto più sicuro del mondo, un posto dove per un attimo i pensieri si quietano e nessuno verrà a cercarti.
Le risposte che cerchiamo possono soddisfare le assenze?
Alle volte, al bivio di una scelta, si decide di cercare ciò che non abbiamo mai avuto ma che abbiamo sempre desiderato con immenso ardore. Sperando che ogni risposta, anche la più dolorosa, possa tacitare la pena che abbiamo nel cuore. Quando arriva non siamo comunque pronti, ma a guardarci intorno, forse, ci accorgiamo che altro ha riempito le nostre vite. Ed è a quel bene prezioso che ci aggrappiamo quando tutto sembra troppo assurdo per essere tollerato.
“Estasiante”
Questo è un romanzo che parla di stivali di pelle tirati a lucido, di un abito da sposa abbagliante, mucchi di lenticchie, rime inventate, vedove solitarie, di solitudini e affetti.
Al lettore non viene risparmiato nulla, seppur tratteggiato con eleganza e sottovoce. Bisogna passare guerre, affrontare malattie mentali, accettare follie ed incesti, assistere ad omicidi efferati e incontri amorosi consolatori dopo le sepolture. In una cornice storica tristemente nota che abbraccia quasi un secolo, l’autore ci mette davanti ad una saga familiare al limite dell’inverosimile. A ben vedere però non si discosta poi così tanto dalla realtà, almeno non da quella che ci rifiutiamo, a volte, di vedere.
Quasi tutto velocissimo è un romanzo sull’imprevedibilità della vita, su una mano di carte sfortunata, su terre di confine, genitorialità e reietti depredati dalle migliori speranze.