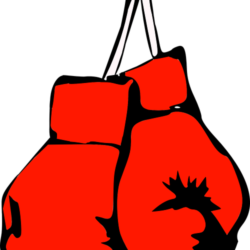di Flavia Catena
Illustrazione di Eleonora Loiodice
I respiri affannati di chi era appena salito appannavano i vetri.
Ben poco da vedere dall’altra parte: l’oscurità delle gallerie faceva risaltare solo i nostri contorni imprecisi, le chiazze di colore che s’incontravano, un cappotto con una sciarpa, un berretto con una mano guantata.
Eravamo compressi, così vicini da reggere, chi con gambe, chi con le braccia, il peso del corpo altrui insieme al proprio. Il nostro silenzio era un insoddisfatto bisogno di leggerezza; sembrava focalizzare le energie nella direzione giusta, sul pensiero giusto.
Il grido che risaliva dalle rotaie, il fischio del vento che entrava dalle porte tra i vagoni, le note sotto cui si accendevano gli schermi in mano ai passeggeri: ciascuno di quei rumori bastava a farci perdere l’equilibrio e la calma. Io resistevo senza sbilanciarmi, incastrata tra un uomo di mezza età, massiccio, e un ragazzo allampanato, un adolescente con in braccio un vecchio cane bianco, gli occhi coperti di lanugine e di paura. A tratti la zampa del cane mi sfiorava il cappotto; ci guardavamo. I suoi occhi velati e i miei si fissavano gli uni negli altri, e in quel momento le porte si aprivano, rimescolando corpi e suoni.
Alla fermata seguente mi disincastrai; l’uomo di mezza età finì spinto via dagli altri passeggeri in uscita, mentre quelli in entrata cercavano di prendere il suo posto relegando me e l’adolescente nell’unico angolo rimasto libero, tra il sedile appena occupato da una donna incinta e il finestrino.
La luce della stazione, oltre il vetro, venne presto annullata dal buio della galleria successiva; il treno sembrò accelerare prima che vi fosse entrato del tutto. Andavamo più veloci che mai, o forse era la nausea a farmelo credere. La zampa del cane non mi sfiorava più il cappotto, ma la gamba: il ragazzo si era accovacciato a terra, e sembrava cercare una via di fuga guardando attraverso gli spiragli che si aprivano tra un piede e l’altro. Ci finii anch’io in quella tana maleodorante, metri sotto terra e sotto muscoli flaccidi, sotto strati di stoffa e ombre.
Caddi, spinta avanti dall’ennesima accelerazione e dalla mancanza di appoggi.
Per dimenticare dove mi trovassi, chiusi gli occhi e contai le stazioni che mi separavano dall’arrivo. Ancora cinque. La voce che le annunciava dall’alto, voce di angelo meccanico, di donna e automa, mi sorprese a tremare nell’attesa di sentire il nome, quella parola unica, diversa da tutte le altre, scandita con più cura, a cui avrei connesso la mia vittoria.
Poi un soffio di vento mi ridestò.
Il cane stava per uscire; da dietro la spalla del padrone continuò a guardarmi fino a quando ebbe raggiunto la banchina. Di nuovo in piedi, gli dissi addio, e lo vidi aprire la bocca. O forse fu la donna che mi trovai accanto a farlo. Decine d’immagini si sovrapposero tra loro in un singolo istante.
Di lei, non vedevo altro che due labbra sottili, linee marcate di corallo. Mordeva qualcosa, un biscotto, una mela; non avrei potuto dirlo per certo, perché si voltava nel farlo. Dietro la cornice della sua valigetta di pelle, un bambino, senza imbarazzo, senza neanche guardarsi intorno, addentava una ciambella: un boccone, e la nascondeva in una scatola di plastica rossa, un altro boccone, e ciò che ne restava finiva di nuovo nella scatola.
Non appena anche la donna dalle labbra sottili scese dal treno, io mi spinsi avanti, abbastanza che a tendere il braccio avrei potuto toccare la porta. Tre fermate, due, ed ecco giunto il mio turno.
Un’anziana sollevò il suo bastone, una ragazza aprì lo scialle che l’avvolgeva, e vidi tutte le stelle che vi stavano stampate dentro come su un cielo notturno. Superai entrambe. Le mie dita si aprivano già verso il mazzo di fiori sul cartellone di una campagna pubblicitaria, il mio piede destro aveva toccato la banchina. Ero fuori, ero quasi fuori.
Accadde allora che un gruppo di ragazzi mi trascinò indietro, un detrito sotto il flusso della loro eccitazione, e il treno ripartì carico fino all’ultimo centimetro quadro, e non più silenzioso. Ai rumori metallici, allo scampanio degli avvisi, allo stridore dei freni, si unì un concerto di schiamazzi, canti, versi animaleschi che contagiò la folla prima composta facendola esplodere. Stazione dopo stazione, il treno che non sapevo più dove andasse e quando si sarebbe fermato, raccolse dieci, venti, trenta nuovi passeggeri, ma non ne lasciò andare neanche uno.
Scoprii allora che quasi tutti avevano una scatola con una ciambella nascosta sotto la giacca, nello zaino, in borsa, e tutti la mordevano, una briciola alla volta, rumorosamente come se fosse dura di giorni, pietrificata dal tempo. C’era anche un levriero dall’altra parte del vagone, grigio e con gli occhi d’ambra, che sembrava addentare un osso, o forse mordeva la caviglia della donna accanto a cui si trovava, e la donna invece di gridare, rideva. Pochi minuti dopo ridevano tutti, persino la voce registrata, la voce d’angelo, di automa, la voce che annunciava la nostra condanna.
Ti è piaciuto questo racconto? Leggi anche quelli delle altre fermate!